Il trittico dell’Assunzione della Vergine di Pietro Novelli
di Anna Terranova, Architetto

L’opera, che rappresenta l’elemento caratterizzante della chiesa dei Cappuccini all’interno del giardino ibleo, si inserisce in una corrente europea d’avanguardia che rispecchiava le riflessioni più attuali all’interno della Chiesa e dell’Ordine dei Cappuccini. Committente fu Niccolò Placido Branciforte, appartenente ad una delle più prestigiose famiglie di Palermo
Nel 1635 il pittore monrealese Pietro Novelli ricevette l’incarico da Niccolò Placido Branciforte di dipingere il trittico della chiesa dei cappuccini di Ragusa. Il trittico con l’Assunzione della Vergine e i due laterali (oggi invertiti) con Sant’Agata e Santa Caterina d’Alessandria, ben riconoscibili dai segni dei loro rispettivi martiri, fu, come dimostra il contratto conservato a Palermo, il frutto delle riflessioni di tre protagonisti dell’epoca: il committente, il potente Niccolò Placido Branciforte, appartenente a una delle più prestigiose famiglie di Palermo, che pochi anni prima aveva fondato la ridente città di Leonforte, il pittore Pietro Novelli, che dagli anni venti era il pittore prediletto della cattolicissima aristocrazia palermitana, e l’Ordine dei Cappuccini. Quest’ultimo aveva svolto un ruolo fondamentale a Leonforte fin  dalla fondazione (e durante la peste del 1627), così come la moglie del Branciforte, Caterina Barresi, attiva collaboratrice del marito nelle scelte di vita personali e politiche. Proprio quest’ultima rappresenta il tramite tra il nobile palermitano e il convento di Ragusa (che comunque doveva conoscere essendo Vicario generale del Val di Noto): la nonna di Caterina, Dorotea Barresi, era stata miracolosamente guarita da un cappuccino, Fra Vito da Ragusa (nel cui esempio Caterina era cresciuta), distintosi poi per la mitezza e la fede dimostrate pochi giorni prima di morire. Niccolò e Caterina, che le fonti ci dicono cattolicissimi, erano particolarmente legati ai cappuccini, come dimostrano sia le importanti donazioni, sia le volontà testamentarie di entrambi.
dalla fondazione (e durante la peste del 1627), così come la moglie del Branciforte, Caterina Barresi, attiva collaboratrice del marito nelle scelte di vita personali e politiche. Proprio quest’ultima rappresenta il tramite tra il nobile palermitano e il convento di Ragusa (che comunque doveva conoscere essendo Vicario generale del Val di Noto): la nonna di Caterina, Dorotea Barresi, era stata miracolosamente guarita da un cappuccino, Fra Vito da Ragusa (nel cui esempio Caterina era cresciuta), distintosi poi per la mitezza e la fede dimostrate pochi giorni prima di morire. Niccolò e Caterina, che le fonti ci dicono cattolicissimi, erano particolarmente legati ai cappuccini, come dimostrano sia le importanti donazioni, sia le volontà testamentarie di entrambi.
Nel 1634 Caterina muore e il devoto marito decide di far dipingere una pala in suo onore, destinata alla chiesa cappuccina di Ragusa.
Caterina, come recita la scritta sullo stupendo sarcofago di marmo nero in cui riposa, – “fortissima nel disprezzo della morte imminente, tenacissima nella fede del mondo celeste” – si era distinta per l’atteg-giamento esemplare avuto in punto di morte, che richiama alla mente quello di Fra Vito, ricordato oltre che per il miracolo a Dorotea Barresi, anche per le parole (pervenuteci) di fede e di gioia avute prima di spegnersi. Così, nel 1635, il pittore Pietro Novelli dipinge la pala d’altare della chiesa di Sant’Agata.
 e dividessero il piano divino, popolato da diversi angeli, da quello umano, caratterizzato dal dubbio e dall’incredulità degli apostoli. Protagonista nel quadro centrale è la luce, ma attraverso un’analisi più approfondita noteremo piuttosto tre fonti diverse: quella centrale, che accompagnerà la Madonna in cielo, non è la stessa che colpisce i volti degli apostoli che si origina invece da un punto in alto a sinistra che un angelo, sportosi sul piano umano, ci indica. Infine la luce che illumina Caterina, di cui un fascio viene dipinto dal Novelli nel quadro stesso (che andrebbe riportato nell’ori-ginaria posizione, a destra), sembra coincidere con la luce delle finestre rivolte a est, la luce del mattino, quindi.
e dividessero il piano divino, popolato da diversi angeli, da quello umano, caratterizzato dal dubbio e dall’incredulità degli apostoli. Protagonista nel quadro centrale è la luce, ma attraverso un’analisi più approfondita noteremo piuttosto tre fonti diverse: quella centrale, che accompagnerà la Madonna in cielo, non è la stessa che colpisce i volti degli apostoli che si origina invece da un punto in alto a sinistra che un angelo, sportosi sul piano umano, ci indica. Infine la luce che illumina Caterina, di cui un fascio viene dipinto dal Novelli nel quadro stesso (che andrebbe riportato nell’ori-ginaria posizione, a destra), sembra coincidere con la luce delle finestre rivolte a est, la luce del mattino, quindi.Le due sante martiri e la Madonna formano i vertici di un triangolo, ribadito anche dalle stupende cornici originali, opera di un frate del convento, con in cima lo stemma mariano: le tre vergini stanno infatti per raggiungere Cristo, rapite dalla sua luce. Tuttavia il pittore fa una netta distinzione: mettendo in risalto il martirio che le due sante subirono, sottolinea che meritarono, si guadagnarono, la resurrezione, al contrario della Madonna che, lontana dal dolore dell a carne, la ottenne per grazia, gratuitamente da Dio. La prima luce, centrale, sarà quindi quella della grazia divina riservata alla Madonna sotto forma di morte e resurrezione.
a carne, la ottenne per grazia, gratuitamente da Dio. La prima luce, centrale, sarà quindi quella della grazia divina riservata alla Madonna sotto forma di morte e resurrezione.
La scelta di ritrarre Santa Caterina nel pannello di destra fu dovuta non solo al nome della defunta moglie del committente, in onore della quale venne realizzato il trittico, ma anche alla storia della santa.
Coerentemente a quanto ci dicono le fonti, Caterina è raffigurata totalmente pronta ad essere sottratta alla vita terrena da quella luce che la investe dalle finestre esposte ad est e che è ribadita dal lampo dipinto.


Per quanto riguarda la terza luce, quella che colpisce gli apostoli e la cui fonte un angelo a sinistra si affretta a indicare ai due che confabulano all’estremità della scena, il contributo che diedero i cappuccini della chiesa dovette essere fondamentale. Il tema della pala, il significato di quella luce, è infatti quello della fede (e la scelta, arbitraria, del Novelli di aggiungere l’episodio della donazione della cintola all’incredulo San Tommaso non sarà casuale) intesa nell’ottica cappuccina, in cui è centrale l’insegnamento di San Bonaventura, ovvero di punto di partenza di quell’itinerario dell’anima che porta al ricongiungimento con Dio. All’estrema sinistra notiamo due apostoli molto particolari: il Novelli si è autoritratto in ascolto di ciò che un personaggio anziano, vestito col saio, gli sta sussurrando all’orecchio, in una posa molto simile a quella in cui si era autoritratto pochi mesi prima in un quadro dell’abbazia benedettina di Monreale, in cui un cavaliere al suo fianco sembra spiegargli il miracolo a cui stanno assistendo.
Come lì, è quindi probabile (e il disegno preparatorio sembrerebbe confermarlo) che il Novelli si sia ritratto mentre un cappuccino, probabilmente il guardiano del convento nel 1635, Fra Battista da Scicli, gli spiega cosa sta accadendo: il miracolo della fede, nell’ottica di San Bonaventura.

Ques
 ti pensieri nel primo Seicento attraversavano tutta Europa, e soprattutto la scolastica spagnola (il domenicano Bañes e il gesuita De Molina) aveva sviluppato importanti riflessioni sulla partecipazione o meno dell’uomo alla grazia, intorno alle quali ruotavano le conversazioni dei maggiori circoli aristocratici (quindi anche quelli di Palermo al cui interno si erano formati Novelli e Branciforte). Le riflessioni sulla Provvidenza erano inoltre centrali nella dottrina della chiesa appena uscita dalla Controriforma. Quest’opera del Novelli si inserisce dunque in una corrente più vasta, assolutamente all’avanguardia, che rispecchia le riflessioni più attuali all’interno della chiesa e di un ordine a cui il committente era particolarmente legato.
ti pensieri nel primo Seicento attraversavano tutta Europa, e soprattutto la scolastica spagnola (il domenicano Bañes e il gesuita De Molina) aveva sviluppato importanti riflessioni sulla partecipazione o meno dell’uomo alla grazia, intorno alle quali ruotavano le conversazioni dei maggiori circoli aristocratici (quindi anche quelli di Palermo al cui interno si erano formati Novelli e Branciforte). Le riflessioni sulla Provvidenza erano inoltre centrali nella dottrina della chiesa appena uscita dalla Controriforma. Quest’opera del Novelli si inserisce dunque in una corrente più vasta, assolutamente all’avanguardia, che rispecchia le riflessioni più attuali all’interno della chiesa e di un ordine a cui il committente era particolarmente legato.
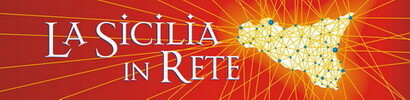


Customer Reviews
Thanks for submitting your comment!